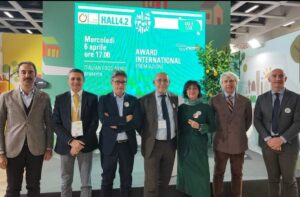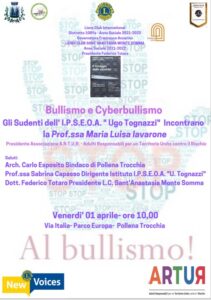L’osservatorio poetico di Luigi Fontanella si dota fondamentalmente di due zone privilegiate e trova pieno compimento ne “L’adolescenza e la notte”. L’adolescenza rappresenta il massimo del desiderabile; la notte, il mezzo: l’informale impalpabile dove il sogno può dare forma al verisimile-eterno. Questa premessa è necessaria. Serve ad inquadrare bene la struttura entro cui si muove la lingua di Luigi Fontanella che non dimentica d’essere poeta scrivendo per il teatro.
“Tre passi nel desiderio” (Neos Edizioni La Mandetta, Torino 2021), sono tre atti unici che spiegano e si spiegano anche in questa sintetica premessa. Ma ragioniamo con ordine. Il titolo evidenzia un andare, un entrare dentro al desiderio, a passi, per coglierne la natura e le mutazioni.
Ne sono tre: il primo passo, un atto unico “Don Giovanni a New York”. E’ un don Giovanni moderno e americano, un John attempato in un soggiorno di un grattacielo di New York che si specchia nel ritratto a mezzo busto di un gentiluomo del seicento alla parete. Dalla finestra ampia sullo sfondo si muovono ad intermittenza le luci di Manhattan. John non aspetta Godot; almeno, non nello specifico ma la ragazza dell’agenzia, quella richiesta per fargli da baby-sitter.
Quando arriva nasce un dialogo, vivace e persino giocoso, in bilico tra il surreale e l’assurdo in cui lo sconcerto della ragazza sorpresa dalla presenza dell’adulto al posto del bambino e gli equivoci che nascono dalle sue richieste, danno al dialogo una in-comunicabilità gustosa ed ammiccante. Il desiderio qui traspare come un nudo velato. L’atto mostra un John voglioso, anche, di rompere il quotidiano.

Il proporsi bambino con la trovata-richiesta, continuamente rinnovata, di baby-sitter all’Agenzia, nel mentre evidenzia un gioco a nascondino fra l’adulto e il bambino, propone un piacere sensuale camuffato da innocenza. Certo, ci sono tutti i patimenti dell’uomo moderno, tutti i sintomi del pansessualismo freudiano o meglio ancora, della personalità junghiana dove entra l’io, l’inconscio personale, i suoi complessi, l’inconscio collettivo, i suoi archetipi, la persona, l’anima e l’ombra.
Il nostro poeta Fontanella conosce bene queste cose. Ne conosce bene molte altre che appartengono al suo inconscio personale ma non ne resta mai ingabbiato come ci spiega bene il suo grande lettore Paolo Lagazzi al termine delle sue riflessioni. La sua creatività trova sempre il modo di rinnovare l’acquisito riproponendolo in modo completamente spiazzante. Il comportamento di John adulto è condizionato sia dal passato come realtà sia dal futuro come aspirazione, addirittura additandolo come passato.
La natura del suo desiderio nel presente, la sua ricerca del piacere non può non fare i conti con la memoria e con il tempo. Può ritrovarlo solo con l’immaginazione: nel paradiso perduto della sua adolescenza. E di questo è convinto anche il regista Sauro Albisani che inizia la prefazione così: – Palcoscenico e cielo, tempo drammaturgico e tempo storico, psiche e meteorologia convivono intimamente nel teatro di Luigi Fontanella (…) – Il poeta Fontanella è sempre in viaggio ed il moto in avanti presenta sempre un paesaggio che gli viene incontro a ritroso.
Il secondo passo avviene con un altro atto unico: “(W)ASH”. A Long Island c’è, in un interno di un villino bifamiliare, Emily che si accinge al trasloco. Disordine ovunque, scatoloni semipieni, ninnoli da incartare e la solita finestra ampia che mostra un po’ di esterno: un’insegna intermittente luminosa “Car Wash” che perde il “Car” per difetto di luminosità, e, talvolta, anche la W di “Wash”. Il difetto dà alla scritta tutto un’altra designazione: L’autolavaggio (Car WASH), nel suo moto scintillante, per accidente, diventa prima lavaggio (WASH) e poi cenere (ASH).
La scena di per sé transitoria, si mostra precaria e nella successione delle luci e in quella dei significati della scritta provenienti dall’esterno. Ma c’è di più. Emily che si aggira nel disordine, distratta da una telefonata, fa un balzo quando si accorge con spavento, stupore e tenerezza della presenza in poltrona del padre morto da tempo. In breve alla sorpresa segue il desiderio dell’accoglimento. Il sovrumano diventa l’equivalente del sogno che permette di soddisfare il piacere del dialogo affettuoso e naturale con il papà per goderne affetto e compagnia. Anche qui in fondo l’ombra del teatro dell’assurdo di Beckett è assai presente ma i dialoghi del teatro di Fontanella sono sempre naturali e sensati.
E’ nel processo creativo della struttura che si ha bisogno sempre della differenza di potenziale tra il reale e il desiderabile, tra parola e simbolo, tra movimento e stasi, tra orizzonte prossimo ed orizzonte remoto. – (…) …sì il tempo…il tempo se ne è andato, e tutti questi anni sono volati, si sono svuotati di tempo (…) E tu rimandavi sempre il nostro ritorno in Italia, rimandavi, cioè, la realtà che stavi comunque vivendo, a un momento futuro ma inesistente…Un futuro nel quale noi avremmo riscoperto la nostra aria nativa… (…) – così Emily a suo padre (fantasma).
Non è lo stesso meccanismo de “L’Adolescenza e la notte”?
Il terzo passo è “MAIL”. La messa a fuoco del desiderio-piacere di comunicare. Qui l’operazione sembra davvero disperata. Forse anche per questo l’atto unico ha bisogno di tre momenti scenici. Attenzione sono tre giornate diverse e il passaggio dall’una all’altra è segnato dall’abbassamento delle luci (notte) seguito dalla graduale illuminazione della scena (giorno). Ogni scena inizia con la luce e termina con il buio. “Adolescenza e notte” anche qui, non vi pare?
In una grande metropoli un uomo sempre di mezza età, cerca presso l’I.C.A. (Intercommunications Center Agency) la sua cassetta postale per recuperare la posta ricevuta. Trova tutto cambiato, tutto robotizzato, la cassetta scomparsa e l’incapacità di avere una comunicazione uomo-donna o uomo-uomo utile per ritrovare la posta scomparsa. La situazione sembra disperata fin quando il nostro cinquantenne Alan non riesce ad intavolare una comunicazione con Gaby (trentacinquenne impiegata dell’I.C.A.) basata sul desiderio-piacere reciproco d’incontro, che, addirittura, rende possibile infrangere tutte le regole dell’Agenzia per recuperare la posta. Ed infatti la posta si recupera. Ma bisogna fare i conti con il terzo incomodo che è il mondo reale (ladri e pistole).
Una tragedia!
Il sogno dell’atto d’amore capace di infrangere le fredde regole della modernità sembra essere pura utopia. Tuttavia è pur sempre questo che resta all’homo sapiens per accendergli la speranza: il suo bisogno di poesia.
Per concludere, questi tre atti unici, sono così ricchi di sincera poesia, cioè di vita vera imprigionata o meglio abbracciata da parole da farmi pensare ad un romanzo autobiografico più che a personaggi da mettere in scena per goderne e, a ben pensarci, è proprio così perché è questo che fa intendere Luigi Fontanella nella sua nota introduttiva.
Salvatore Violante